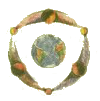Le cime dei monti sono i suoi seni, i fiumi il suo latte di vita e i campi il suo fertile grembo. Pachamama, in lingua quechua. Madre nutriente che dà la vita. È un’esperienza straordinaria volare dove il cielo abbraccia la Madre Terra. Può mostrare però anche il suo lato crudele, quando produce terremoti, per ricordare ai suoi figli che devono sempre onorarla.
Un tramonto caldo e lento colora di rosa e arancio Tiwanaku, patrimonio del mondo. Lama, zigomi andini e case rosse di mattoni, stesso colore della terra intorno. Gli occhi si riempiono di queste immagini a 4000 metri di cultura. Risplendono davanti alla Porta del Sole, unico blocco di pietra di 100 tonnellate. A sud del lago Titicaca, una settantina di chilometri da La Paz, anticamente Nostra Signora della Pace.
Tiwanaku era Chucara. Una città completamente sotterranea. In superficie il cantiere per tagliare le pietre e il villaggio degli operai. La città continua a conservare il suo mistero e nasconde ancora oggi la chiave di una straordinaria civiltà che risale a tempi lontanissimi. Tiwanaku una macchina per misurare il tempo dalla precisione spaventosa, in grado di regolare la vita agricola e religiosa dei suoi abitanti. Sorse in una notte, costruita da un popolo di giganti. Forse ispirati dal cielo delle Ande. Su un territorio che si estendeva lungo le attuali frontiere di Cile, Perù e Bolivia.
Nella mente e negli occhi di Antonio ritornano le letture di bambino, quando Maya, Incas e Aztechi erano favole, leggende di sangue e astronomia. Sogni di viaggio. Ancora immagina, rivivendo quelle pagine d’infanzia, gli stessi spagnoli, affamati d’oro una volta saziati di sangue, trascinarsi fin quassù, bollendo dentro le pesanti armature, in cerca della ricchezza e con l’illusione di trovare il mitico Eldorado.
Le stelle sono vicine, il silenzio è totale. Pachamama era venerata dagli Inca, ora dagli abitanti dell’altopiano andino, Aymara e Quechua. Le popolazioni andine, praticano ancora oggi il culto del ringraziamento alla Pachamama, restituendole il nutrimento che essa fornisce loro.
«Viene scavato un fosso, un’enorme buca nella quale sono riposti alimenti, che vengono cucinati appositamente. Ognuno versa una porzione di cibo, ringraziando la Madre Terra. Al termine la buca viene completamente ricoperta e ogni abitante depone una pietra. Si forma una vera e propria montagnola di sassi. E’ chiamata Apachete. Solitamente si sceglie sempre il luogo più in alto per far sì che sia il più possibile vicino al Sole».
Una lacrima scende dagli occhi grandi di Antonio. La moglie non c’è. Si chiama Valeria e lei quella storia la conosce bene, sin da bambina. Hanno due figlie e un figlio, lavorano in Italia, dall’altra parte del mondo. E lì, in un paese tra Treviso e Venezia dove è nato, vive la sua famiglia.
Antonio oggi ha 68 anni. Valeria 57. Lei è boliviana. Il suo paese d’origine è al confine con il Paraguay, una sessantina di chilometri da Monteagudo, nella Ruta del “Che”. All’età di 11 anni era finita in un orfanotrofio. E’ il 1964, l’anno del colpo di Stato militare che portò alla presidenza il generale Barrientos Ortuno. Fu durante il suo governo che s’infiammò la guerriglia del “Che” nel dipartimento di Santa Cruz. E fu lui a dare l’ordine di assassinare Ernesto “Che” Guevara il 9 ottobre del 1967.
Antonio a Tiwanaku è di casa. Aveva 21 anni la prima volta che arrivò in Bolivia come volontario salesiano. Dopo aver frequentato un paio di anni la scuola di Don Bosco a Torino e imparato il mestiere di tipografo, gli venne proposto di andare a La Paz. A quell’età e in quei tempi una scommessa sulla vita. Una sfida che raccolse subito. Anni difficilissimi in America Latina governata dai militari. Colpi di stato uno dietro l’altro da destra e da sinistra.
Ad un tratto fra enormi pietre, là in alto sulla punta di quella roccia rossa, sembra di vedere per un attimo, un vecchio Inca. Forse un sacerdote che a occhi chiusi, come in trance, prega offrendo piccoli animali a Inti, il dio sole, a suo fratello vento e alla Pachamama, la natura madre dolce e generosa. E canta nenie impercettibili dondolandosi avanti e indietro.
«I boliviani sono cattolici, ma la religione è fortemente contaminata da credenze tradizionali indiane. Come l’adorazione del Sole, della Luna e della Terra. E’ questo che bisogna saper anche cogliere in questi luoghi» dice Antonio.
Siamo qui, sbarcati dopo un viaggio di 27 ore da Venezia, e la magia di questi luoghi ti rapisce senza che ti accorgi di nulla.
Oggi è il 21 giugno del 2010. Primo giorno d’inverno in Bolivia, primo giorno d’estate in Italia. Migliaia di persone hanno accolto a Tiwanacu l’inizio dell’anno 5518 del calendario aymara. C’è anche il presidente della Bolivia, Evo Morales. Questa mattina ha chiesto la benedizione della Madre Terra e del Padre Sole per tutti i popoli andini. Davanti al tempietto di Kalasasaya seguo i riti con Antonio. E’ un ampio cortile, oltre trecento metri di lunghezza. Ci mescoliamo tra i mallkus e amateus, i capi e saggi indigeni. Hanno atteso tutti con le mani in alto i primi raggi del sole, per potere percepire la sua forza ed energia.
Durante uno dei riti, gli amateus hanno sacrificato alcuni lama. Hanno versato il loro sangue sulla terra, insieme a foglie di coca e alcol. E invocato la fertilità per l’agricoltura e i ringraziamenti per i doni ricevuti. Il 21 giugno, qui, è festa nazionale. E si beve come non mai in tutto l’altopiano. Il consumo di alcol non è gestibile, anche perchè serve per combattere il freddo. Si commemora il solstizio d’inverno. È conosciuto con il nome di Willakakuti nella zona andina e di Yasitata Guasù nella pianura.
Siamo davanti alla Porta del Sole. L’architrave è scolpito con 48 effigi alate ciascuna in una piazza, 32 con volti umani e 16 con le teste di condor. Tutti guardano alla figura centrale, ma la sua identità ancora oggi è un’enigma. Il condor delle Ande, uno degli uccelli più grandi del mondo con un’apertura alare di tre metri, può trasportare senza sforzo carcasse anche di venti chili. E lo fa ancora oggi.
E’ la prima volta a Tiwanaku per me. Chiudo gli occhi. E le parole, tra migliaia di andini, diventano silenzio. Antonio mi sussurra all’orecchio una preghiera. Parole che dondolano ancora.
«Terra, Dea divina, Madre Natura, che generi ogni cosa e sempre fai riapparire il sole di cui hai fatto dono alle genti. Guardiana del cielo, del mare e di tutti gli Dei e delle potenze, per il tuo influsso tutta la natura si quieta e sprofonda nel sonno. E di nuovo quando ti aggrada tu mandi innanzi la lieta luce del giorno e doni nutrimento alla vita con la tua eterna promessa. E quando lo spirito dell’uomo trapassa è a te che ritorna. A buon diritto invero tu sei detta Grande Madre degli Dei. Vittoria è il tuo nome divino. Tu sei possente, Regina degli Dei. O Dea io ti adoro come divina, io invoco il tuo nome, degnati di concedermi ciò che ti chiedo, in modo ch’io possa in cambio colmare di grazie la tua divinità, con la fede che ti è dovuta».
Gli occhi di Antonio diventato rossi. Scende una seconda lacrima.
«La terra è nostra madre, ha un’anima. Quella preghiera è conservata all’erbario inglese del XII secolo del British Museum. Tutti gli esseri umani, a partire dai governi nazionali, devono rispettare la terra. I diritti della Madre Terra sono più importanti di qualsiasi altro diritto umano, perché rispettarla significa difendere l’intera umanità. La terra e i suoi prodotti non devono essere convertiti in merce. Tutti siamo suoi figli. Se la percezione del pianeta non cambierà nessuno si salverà, nemmeno chi possiede mezzi e ricchezza».
E’ l’inizio di un viaggio. Amori boliviani per questa terra. E anche l’inizio di un viaggio dentro un altro viaggio. Una sfida nata da un desiderio d’amore che vive: scoprire le origini della moglie Valeria.
……………………………………………………
«Amo il sale della terra, amo il sale della vita….». Antonio canta Rino Gaetano, una meteora della musica italiana. Qui dove la terra è sale, il sale è vita. Qui, sulle Ande boliviane, che lasciano di sale il visitatore per la loro bellezza mozzafiato. Ogni sforzo si paga caro a oltre 3.600 metri sul mare. In questo immenso e candido deserto circondato da vulcani, nel sud-est di Potosi, 750 chilometri da La Paz. E’ parte dell’altopiano confinante con Cile e Argentina, dove esistono solo il bianco e il blu. E dove per 250 chilometri da est a ovest e per 150 da nord a sud il cielo si fonde con il sale. E’ il Salar de Uyuni. Oltre a costituire il giacimento di sale più vasto e alto della terra è una delle maggiori riserve di litio del pianeta. Giapponesi e cinesi proprio in queste settimane stanno cercando di chiudere un accordo di milioni di dollari. Il litio nell’industria elettronica fa gola. E non solo come materia prima per le batterie.
Un giorno intero di viaggio con Antonio da La Paz.
«Salar è bellezza, magia, avventura, paesaggio unico, selvaggio, estremo. Da giugno a settembre le temperature notturne precipitano da +14 a -10. Nei pochi alberghi acqua calda riscaldamento e luce sono precari. I telefoni tacciono. Internet forse arriverà in una delle strutture che circondano questo pianoro ricoperto di uno strato di 2-10 metri di cloruro di sodio, che perennemente si rinnova».
Antonio mi guarda, sorride e spalanca gli occhi. Poi un abbraccio fortissimo. Come a un fratello.
«Sei più giovane di me di 12 anni. Hai capelli e barba bianchi. Hai girato tutto il mondo. Sei andato anche per guerre. Hai scritto libri. E abbiamo lavorato insieme per tanti inverni e primavere. Ho cercato più volte di convincerti a volare dove il cielo abbraccia la Madre Terra. Adesso, dieci anni dopo, finalmente ci sono riuscito. Sei qui nella terra boliviana. E io sono felice. La nostra amicizia è più grande ancora, indissolubile».
Una mattina di sei mesi prima, sulla mia scrivania in redazione, di ritorno da uno dei viaggi in Bolivia Antonio aveva appoggiato un cd. C’erano memorizzati un video, fotografie e musica. E poi sul tavolo anche un libricino colorato con volti di bambini. Orfani, tutti sorridenti. E un biglietto.
«La Bolivia ti aspetta da anni, quel giorno è arrivato. Ciao Antonio».
Quei sorrisi di bimbi erano riusciti a emozionare il mio cuore. Sì, perchè sono stato sempre convinto che a muovere le cose nel mondo, alla fine, è soltanto il cuore. Vivo sapendo di non sapere. Vivo come se oggi fosse sempre il mio primo e il mio ultimo giorno di vita. Antonio è felice. E io ancora di più.
«Bisognerà trovare un alloggio per la notte e provvedere anche al pieno di gasolio della jeep, presa a noleggio. Se ci si accontenta delle pensioncine molto spartane, con letti di sale in stanze gelide con sacco a pelo e scarpe resistenti potremmo risparmiare anche tanto. Troveremo cibo, sano e saporito, a base di quinua e carne di lama».
Sulla strada di terra s’incontrano animali e bambini.
«Troppo spesso la Bolivia è considerata semplicemente la sorella povera del Perù. Non è vero. La popolazione di questo Tibet americano è tra le più pure e incontaminate del continente e nelle vene dei due gruppi autoctoni scorre sangue amerindo, così come all’epoca incaica risalgono molti usi e tradizioni degli indios, compresi i coloratissimi abiti di lama».
Qui davanti al sale della vita, Antonio apre il suo cuore e mi confida il suo segreto: quell’amore boliviano. Seduti dentro la jeep e davanti al Salar. Lo fa in silenzio con i colori del bianco e blu. Gli unici possibili in questo microcosmo. C’è sempre in ogni storia, un inizio e una fine. Quella di Antonio è una storia senza fine. L’inizio, invece, c’è nel 2000. L’ascolto tutta d’un fiato, poi in quel silenzio la ripercorrono dentro la mia mente.
……………………………………………………
Bambini che camminano aggrappandosi alla mano di nessuno lungo la strada oscura della vita. Sono cosí forti e cosí fragili. Cosí esperti e cosí innocenti. Cosí lucidi e cosí folli. Non conoscono lo zucchero filato, né i carillon.
Quando a otto anni si conosce invece l’angoscia della “clefa”, colla da sniffare, la marijuana o altri tipi di stupefacenti, o si dorme in un canale della fognatura, o si ha come unico legame familiare una banda di delinquenti di strada, si é giá superato il limite dell’infanzia. Vivere nelle strade in queste condizioni equivale esattamente a vivere nell’inferno. E’ uno spazio di disuguaglianze, con le sue proprie leggi e dove sopravvive quello che è più furbo e forte, perchè non c’è alternativa.
E’ la cruda realtá. Se racconti loro di Babbo Natale, si mettono a ridere. Perché, chiaro, da lui non si aspettano nulla. Loro giocano con ció che capita nelle mani e per caso. Litigano per qualsiasi cosa. Si raccontano, quando qualcuno si rivolge loro in modo diretto, attraverso i dolori. Le loro tenerezze, i sogni e le speranze.
……………………………………………………
«L’8 ottobre 1967, una frase in codice “papà cansado”, per voi in italiano significa papà è stanco, viene trasmessa via radio a La Paz: è la notizia che il Che è stato catturato. Dopo 18 ore di calvario viene ucciso. Susanna, l’infermiera che prese in consegna il cadavere del Che, è ancora viva. Andiamo a trovarla. Abita qui, nel mio paese. Dopo aver fatto l’infermiera, sino a non molto tempo fa, lavorava in un negozio e vendeva un po’ di tutto».
Quando le portarono il corpo, gli ufficiali la obbligarono a lasciare tutti gli altri malati per occuparsi solo di lui. Quegli occhi del Che bianchi e spalancati le sono rimasti dentro la mente fino ad oggi. Se li sogna molte volte la notte.
«Sembrava che mi guardasse dritto nel cuore. Pareva Gesù Cristo. Ricordate quelle foto? Il corpo del Che sulla barella, a torso nudo, con gli occhi aperti? Quelle immagini girarono su tutto il pianeta. Il cadavere fu affidato a due infermiere che lo lavarono, preparandolo alla sepoltura. Una ero proprio io»……………………….